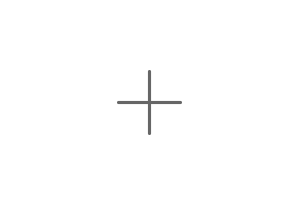La piccola Cappella di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola, che potete vedere ancora intatta all’interno della Basilica, fu eretta secondo la tradizione da quattro reduci dalla Guerra Santa che riportarono in patria un frammento della tomba della Madonna, nella piana boscosa sottostante Assisi, detta appunto Cerreto della Porziuncola. Lì, in certe giornate autunnali, il vento forte che spazza via ogni nuvola dal cielo, passando fra le fronde degli alberi, sembrava somigliare al canto degli angeli. La cappella fu gestita dai monaci benedettini di San Benedetto al Subasio a partire dal X secolo. Probabilmente questo luogo sarebbe stato completamente dimenticato se le strade di Francesco e Chiara non lo avessero incrociato. Grazie a loro oggi possiamo vedere la Porziuncola intatta, com’era più o meno mille anni fa. Ma al posto della chiassosa boscaglia c’è un’enorme basilica, costruita fra il ‘500 e il ‘600, che la ingloba e la protegge come una mamma premurosa. Vista così, dall’interno della pancia, sembra ancora più piccola, incredibilmente piccola.
La Chiesa fu donata al Santo poverello dagli stessi monaci benedettini per istituire il campo base del costituendo ordine Francescano. Quando Francesco passò qui per la prima volta la chiesa era in stato di abbandono e la sua agiografia narra che dedicò il terzo anno dopo la sua conversione interamente alla ristrutturazione della piccola cappella. Proprio qui egli realizza leggendo il Vangelo che la sua missione non era restaurare gli edifici religiosi cadenti, ma restaurare e predicare il Regno di Dio tutto, vivendo in povertà, penitenza e semplicità. Da qui Francesco e i suoi confratelli partivano per portare il proprio messaggio in giro per l’Italia, e qui sempre facevano ritorno. Nella notte del 1211 bussò alle porte della Porziuncola Chiara d’Offreduccio, disperata e terrorizzata, scappata di casa e dalla sua aristocratica famiglia. Qualche giorno più tardi in questa cappella ella prese i voti e fece la sua promessa di penitenza per essere consacrata a Dio e iniziare il suo viaggio spirituale, che la portò a fondare il movimento femminile francescano delle Clarisse e divenire la santa più importante della città.
Nella Porziuncola nel 1216 venne istituito per la prima volta il “Perdono di Assisi”, un rituale di indulgenza plenaria nel quale si stabiliva che chiunque entrasse all’interno della Chiesa con sincero spirito di pentimento sarebbe stato dopo la confessione istantaneamente assolto da tutti i peccati commessi. L’indulgenza era una pratica frequente all’interno della Chiesa cristiana durante il Medioevo, ma fino ad allora per ricevere l’assoluzione era necessario pagare un “obolo”, cioè un corrispettivo di denaro che potevano permettersi solo i ricchi, compiere un lunghissimo pellegrinaggio nei luoghi più importanti del Cristianesimo come la Città Santa, oppure eseguire speciali pratiche di mortificazione della carne, per esempio il digiuno forzato o dormire su un letto di ortiche. Francesco riuscì ad ottenere questa straordinaria “deroga” presentandosi di persona da Papa Onorio III e convincendolo della santità della sua richiesta. Tornato ad Assisi, da un pulpito montato appositamente all’esterno della Porziuncola, fece il glorioso annuncio davanti a migliaia di persone in visibilio. Il “Perdono di Assisi” fu una pratica controversa e molto dibattuta all’interno della Chiesa nel corso della storia. La regola fu nel corso del tempo modificata molte volte. Prima fu estesa a tutte le chiese francescane, poi a ogni chiesa parrocchiale ma il rituale venne ridotto a due soli giorni all’anno: il 1° e il 2 agosto. Nel 1988 la Penitenzieria Apostolica stabilì che all’interno della Porziuncola l’indulgenza poteva essere ricevuta in ogni giorno dell’anno, riconfermando l’importanza straordinaria che questo luogo detiene per il mondo cristiano.
All’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, a qualche passo dalla Porziuncola, vi è il luogo dove Francesco volle essere portato per passare i suoi ultimi istanti di vita, e scrivere l’ultimo verso del suo Cantico delle Creature: la Cappella del Transito. In questo angusto spazio, ciò che rimane dell’infermeria del vecchio convento che venne costruito per ospitare i frati, Francesco venne assistito fino all’ultimo respiro, avvenuto la notte del 3 ottobre 1226. Nella Cappella vi sono alcuni affreschi eseguiti da un allievo del Perugino, detto lo Spagna. Dietro l’altare c’è una splendida e commovente statua di Francesco modellata da Andrea della Robbia, uno dei più caratteristici ceramisti del Rinascimento. Inoltre, sempre all’interno della Cappella, è custodita un’importante reliquia del Santo, il cingolo, cioè la corda con la quale Francesco si stringeva alla vita il suo saio.
La notizia del Perdono d’Assisi si diffuse in Italia e in Europa velocissima e già a partire dai giorni direttamente successivi all’annuncio di Francesco la Porziuncola diventò meta di pellegrinaggi continui. Nella seconda metà del ‘500 il flusso di pellegrinaggi è talmente alto che venne deciso di ampliare la chiesa e costruire altre strutture ricettive. Su progetto di Galeazzo Alessi, nacque la maestosa Basilica di S. Maria degli Angeli, lunga 126 metri e larga 65, in grado di ricevere le centinaia di migliaia di pellegrini che la visitavano ogni anno. Il progetto fu così ambizioso che la costruzione della chiesa durò più di un secolo.
In realtà noi oggi riusciamo a vedere molto poco dell’originale progetto del grande architetto perugino. L’Ottocento fu un secolo molto buio per la Basilica: prima i saccheggi effettuati dall’esercito napoleonico e poi il violentissimo terremoto del 1832 devastarono in gran parte l’edificio. La cupola progettata dall’Alessi crollò rovinosamente sopra la Porziuncola, che rimase intatta come per miracolo. Negli anni successivi i lavori di ristrutturazione cambiarono abbastanza la conformazione della chiesa. La facciata, che culmina con la caratteristica statua della Madonna in bronzo dorato, è stata ultimata nel 1930. Del progetto originale rimangono solo l’abside e la cupola, ricostruita in soli otto anni dal suo crollo. All’esterno, sulla parete sinistra della Basilica che affaccia sulla via per Assisi, vi è addossata la Fonte delle 26 cannelle. Una fontana che corre per quasi tutta la lunghezza della parete fatta costruire dalla famiglia Medici nel 1610, anche loro grandi devoti di S. Francesco. Nelle decorazioni che abbelliscono in maniera alternata i becchi di fuoriuscita dell’acqua potrete scorgere uno scudo con sei sfere in rilievo. Tale simbolo rappresentava proprio lo stemma della famiglia fiorentina, con cui erano conosciuti in tutta Europa.
L’interno della Basilica, diversamente da quello dell’omologa Basilica di San Francesco, è semplice e scarno, non molto decorato, in piena armonia con i principi della Regola francescana. È composto da tre navate e ogni navata laterale ospita cinque cappelle, le uniche zone della Basilica con affreschi e decorazioni, commissionate nel corso degli anni da famiglie nobili devote o da istituzioni comunali.
La Porziuncola è posta al centro esatto della basilica di Santa Maria degli Angeli come un solido nucleo da cui tutto si sprigiona. Al suo interno, sulla parete dietro l’altare, vi è una tavola che dipinse Ilario da Viterbo nel 1393 che narra le vicende del Perdono d’Assisi. La storia, che come abbiamo visto si conclude con un glorioso annuncio davanti a migliaia di persone, comincia in realtà a qualche metro di distanza dalla chiesetta, nel roseto di un cortile adiacente alla Basilica. Secondo l’agiografia la visione che spinge Francesco ad andare a chiedere al Papa l’indulgenza del Perdono è anticipata da una grossa e misteriosa tentazione che il frate si trova ad affrontare mentre era assorto in un momento di preghiera. Per non cadere nella trappola egli si spogliò e si gettò nel roseto, che istantaneamente perse tutte le spine. Ancora oggi la “Rosa Canina Assisiensis“, che cresce in quella parte del convento, non presenta traccia di spine. La cappella che sorge in prossimità del roseto, innalzata in memoria di questo evento miracoloso, conserva in una grotta sotterranea le travi che si dice formarono il pulpito dal quale Francesco annunciò il Perdono.
Sebbene non ci siano famose opere d’arte in questo luogo, la Basilica e la Porziuncola costituiscono un’esperienza di visita unica, che si può vivere anche solo immaginando le storie e i personaggi che hanno attraversato in più di un millennio questi spazi. Dall’esterno o dall’interno della Basilica, con un po’ di fantasia, è possibile rivedere le scene delle adunate oceaniche che inondavano la chiesa per la ricorrenza del Perdono; oppure all’interno della Cappella della Porziuncola potrete rivivere l’intimità della consacrazione di Chiara, appena diciottenne, spogliata e totalmente abbandonata a Dio, mentre Francesco le taglia i capelli alla luce di fioche e tremolanti lanterne a olio.
Ma se ciò non bastasse, la Basilica di Santa Maria degli Angeli riserva ancora delle sorprese per scoprire le quali vi basterà dirigervi verso il Museo della Porziuncola. Il museo ospita alcuni capolavori dell’arte cristiana e francescana, a partire dall’antichissimo crocifisso di Giunta da Pisano, datato 1236, uno dei primi crocifissi in cui è raffigurato il cristo patiens, cioè umanizzato e sofferente, contrario allo stile predominante dell’epoca ‒ di ispirazione greco-bizantina ‒ del cristo Triumphans glorioso e trionfante pur nell’atto della sua crocifissione. Possiamo considerare Giunta da Pisano, insieme a Cimabue e Giotto, uno dei massimi innovatori dell’arte medievale, tra i primi che gettarono le basi per l’arte rinascimentale. Tra le tante opere d’arte e oggetti preziosi il museo conserva due tavole dipinte che raffigurano entrambe S. Francesco, la cui storia, come spesso accade, si mescola con il mito. La prima è del Maestro di San Francesco, la misteriosa mano che produsse anche molti affreschi all’interno della Basilica di San Francesco, ed è la più antica immagine di Francesco mai trovata, risalente alla metà del 1200. Collocata inizialmente nella Cappella del Transito, si dice che l’opera sia stata dipinta sulla stessa tavola dove Francesco usava coricarsi e sulla quale ha esalato l’ultimo respiro. La seconda tavola è attribuita a Cimabue per la straordinaria somiglianza al ritratto del Santo che il maestro fiorentino dipinse nella Maestà della Basilica inferiore di S. Francesco, il ritratto più fedele di cui disponiamo. Anche qui il mito vuole che la tavola che costituisce la base del dipinto sia stata il coperchio del feretro nel quale inizialmente venne custodita la salma di Francesco. In una delle sei sale di cui è composto il museo troverete anche un’altra pregevole opera di Andrea della Robbia: un dossale di lucente terracotta invetriata, datato 1475 circa, che raffigura scene sacre e storie francescane, fra cui anche la scena in cui San Francesco riceve le stimmate, nel Santuario di La Verna. Storia, arte, spiritualità e mito, la ricetta perfetta per un’esperienza unica.